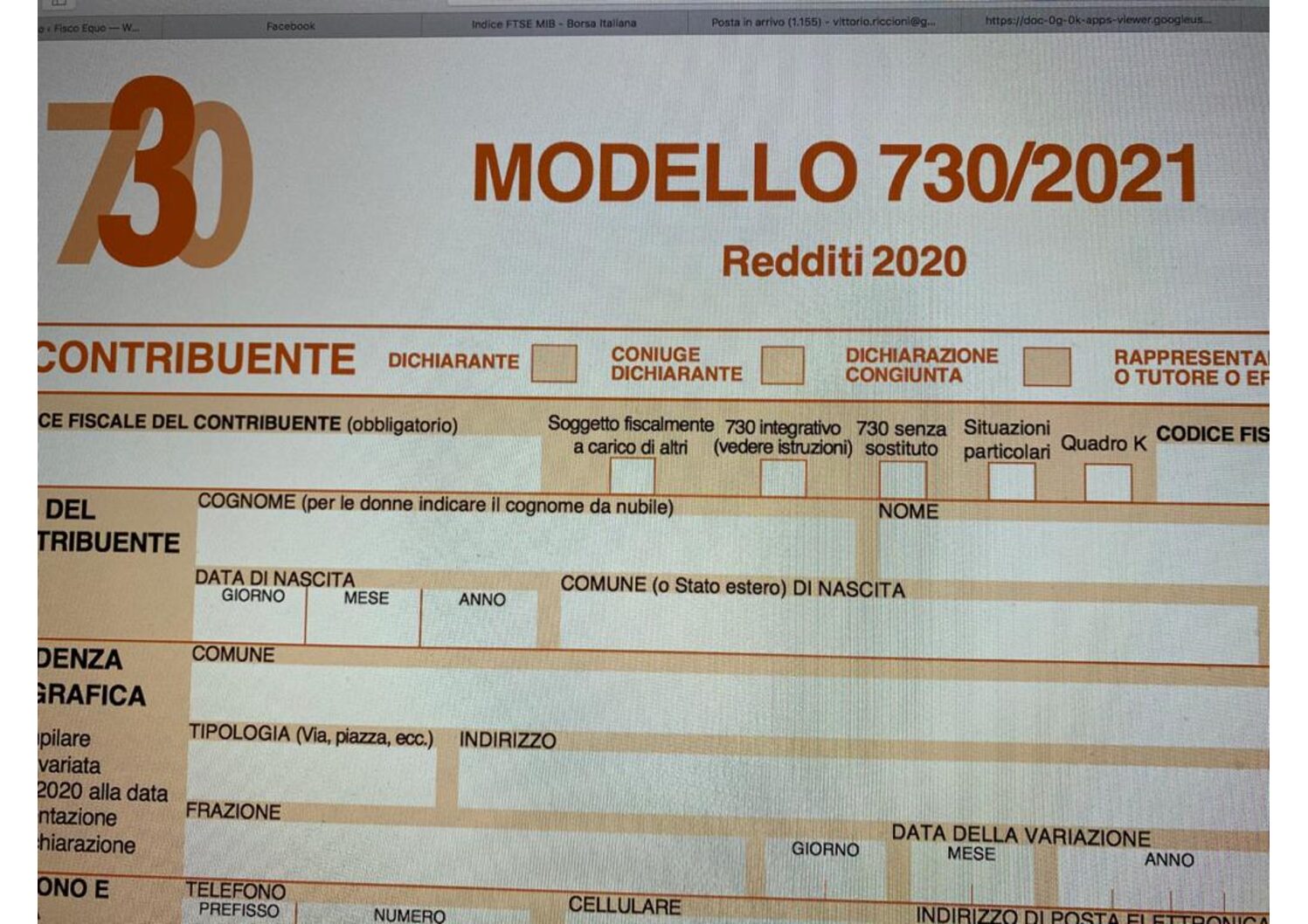Ormai da una ventina d’anni tutte le amministrazioni fiscali dei Paesi economicamente avanzati, per il
contrasto della evasione della massa dei piccoli e medi contribuenti, puntano, con l’aiuto della tecnologia,
su due misure: la tracciatura digitale delle transazioni economiche e il contatto preventivo, a monte della
dichiarazione dei redditi, utilizzando i dati informatici già in possesso del fisco. È una strategia che ha avuto
successo in numerose realtà aumentando in alcuni casi considerevolmente, vedi il Portogallo, la compliance
ovvero i ricavi dichiarati dai contribuenti medio-piccoli che esercitano un’attività economica. In genere
l’importo evaso da questi contribuenti non è elevato ma poiché si tratta di milioni di soggetti il totale
raggiunge una percentuale considerevole, oltre l’80%, del sottratto al fisco.
Per tale ragione non si può non accogliere favorevolmente il provvedimento del cashback in quanto di
sicuro incentiva l’uso della moneta elettronica e quindi la tracciatura digitale delle transazioni economiche,
riducendone l’oscurità e rendendo disponibili all’amministrazione fiscale maggiori informazioni per la
quantificazione effettiva dei ricavi di chi esercita un’attività economica. C’è, inoltre, un’altra ricaduta positiva del provvedimento ed è collegata al fatto che in Italia l’uso della moneta elettronica è in percentuale piuttosto basso rispetto ad altri paesi comparabili con il nostro e che indirettamente ciò è anche conseguenza della scarsa familiarità della nostra popolazione, soprattutto
quella anziana, con il digitale. Risulta, pertanto, utile un incentivo che contemporaneamente promuove la
diffusione degli strumenti di pagamento elettronici diminuendo l’area dell’evasione fiscale possibile.
È opportuno, tuttavia, non trascurare i limiti di questa norma che trova attuazione, a causa della pandemia,
in un momento particolare della nostra storia. È bene anche ragionare su tali limiti anche per individuare e
mettere a punto, se necessari, aggiustamenti in corso d’opera. Infatti, il provvedimento favorisce i soggetti e le famiglie con i redditi più alti in quanto utilizzatori con maggiore frequenza degli strumenti di pagamento elettronici poiché sono in possesso di un maggior numero di carte di credito/debito personali rispetto a chi guadagna meno. Inoltre, le carte di credito e di
debito sono più diffuse nelle famiglie del nord Italia così come sono più diffuse nei centri urbani con
maggiore densità di popolazione e fra chi ha meno di trent’anni. La partecipazione al sistema informatico per ottenere il rimborso è macchinosa in quanto richiede nella grande maggioranza dei casi lo Spid, che solo le Poste rilasciano
gratuitamente e comunque in questa pandemia bisogna fare la fila presso un Ufficio Postale per ottenerlo.
C’è da chiedersi come mai lo strumento alternativo ovvero la Carta d’identità elettronica, il cui rilascio è
iniziato nel 2006, nel 2020 è in possesso solo d’una piccola minoranza di italiani?
Vi è poi la complessità di gestione del proprio diritto al rimborso: occorre una padronanza nell’uso delle
applicazioni sul cellulare che molti anziani ancora non hanno. Sarebbe opportuno monitorare l’effettiva promozione della moneta elettronica in quei pagamenti in cui è più vantaggioso sia per il fornitore che per il consumatore pagare in nero, isolando questo tipo di transazioni da quelle in cui l’uso della carta di credito/debito era già abituale.
Ai fini del contrasto all’evasione c’è necessità d’individuare un possibile uso di questo muovo big-data per
ricostruire gli effettivi ricavi dei fornitori di beni e servizi. Da questo punto di vista c’è da rilevare che già
oggi il sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria dispone di big-data abbastanza esaustivi dei dati
elementari dei conti correnti e dei rapporti finanziari dei singoli soggetti ma una serie di cavilli burocratici,
in nome di una generica privacy, impedisce il loro uso trasparente nella lotta all’evasione o anche
semplicemente per incrementare l’adesione spontanea all’obbligo nel momento della dichiarazione dei
redditi.
In questo momento così delicato per la finanza pubblica in cui per la pandemia in atto c’è bisogno di
aumentare a dismisura il nostro debito pubblico suscita perplessità l’erogazione di cifre premiali, che inevitabilmente andranno a beneficio dei più ricchi e di quanti risiedono nei territori più favoriti, senza un preciso obiettivo economico collegato
al difficile momento che stiamo vivendo. A questo proposito sarebbe utile conoscere e pubblicizzare i
risultati del provvedimento man mano che trova attuazione. Sarebbe, infine, necessario quantificare come
ha inciso la misura sulle modalità di effettuazione degli acquisti in quanto il Cashback favorisce i consumi presso i negozi rispetto a quelli on-line soprattutto per valutare il suo effetto in un momento in cui la pandemia richiedeva la riduzione dei contatti umani con lo stare il maggior tempo possibile in casa.